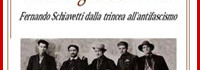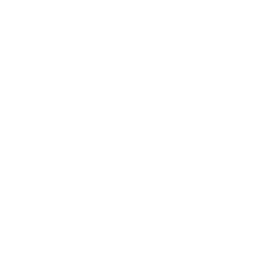Stéfanie Prezioso, Itinerario di un «figlio del 1914». Fernando Schiavetti dalla trincea all’antifascismo, Manduria-Bari-Roma, Piero Lacaita, 2004, XII-390 pp.
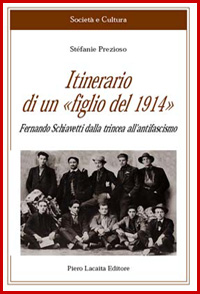 Raramente si ha l’occasione di seguire la formazione politica e intellettuale dei responsabili dell’emigrazione antifascista. Sennonché la conservazione dell’archivio di Schiavetti in Svizzera, prima del suo trasferimento a Firenze, permette a Stéfanie Prezioso di studiare proprio il percorso formativo di un rappresentante della sinistra repubblicana, che capeggiò la scissione della Alleanza repubblicana socialista (ARS), poi confluita in Giustizia e Libertà. L’autrice completa così lo studio di Marina Tesoro ed Elisa Signori, imperniato sull’esilio (Il verde e il rosso. Fernando Schiavetti e gli antifascisti nell’esilio, fra repubblicanesimo e socialismo, Firenze, Le Monnier, 1987) e le memorie della figlia Franca Magnani (Una famiglia italiana, Milano, Feltrinelli, 1990). Prezioso ha voluto comprendere le contraddizioni di un personaggio complesso, nato nel 1892, studente della Scuola Normale, repubblicano interventista atipico, in rivolta contro l’ambiente familiare e il padre questore, ma anche intriso di un rivoluzionarismo che privilegia la piccola borghesia e di un umanitarismo paternalista. Partito verso la Francia nel 1914 senza riuscire a combattervi, poi divenuto non interventista per non vedere la monarchia trarre vantaggio del conflitto, una volta che l’Italia entra in guerra ritrova la retorica dell’eroismo, della giovinezza, della virilità rispondendo così alla realtà del fronte, evoluzione che seguiamo passo passo grazie alla corrispondenza di guerra. Vediamo dunque nascere una descrizione brutale e piena di odio del nemico in quanto individuo, che mancava all’inizio. Tra contingenze occasionali e valorizzazione dell’ego, scopriamo pure l’elaborazione del discorso che scorge nei combattenti i soli rappresentanti qualificati del popolo, nonché il rifiuto della società civile, della retroguardia, dei pacifisti, dei socialisti e persino del PRI definito come ministeriale. Ne consegue l’accettazione dei deliri di Cadorna contro i soldati e il popolo italiano, su di un tono pre-totalitario, e l’impressione di essere stato prescelto dal fato, perché capace di sopravvivere nella battaglia. L’interventismo e il comunitarismo combattente virano verso l’antioperaismo e rafforzano la volontà di rimpiazzare le antiche élite.
Raramente si ha l’occasione di seguire la formazione politica e intellettuale dei responsabili dell’emigrazione antifascista. Sennonché la conservazione dell’archivio di Schiavetti in Svizzera, prima del suo trasferimento a Firenze, permette a Stéfanie Prezioso di studiare proprio il percorso formativo di un rappresentante della sinistra repubblicana, che capeggiò la scissione della Alleanza repubblicana socialista (ARS), poi confluita in Giustizia e Libertà. L’autrice completa così lo studio di Marina Tesoro ed Elisa Signori, imperniato sull’esilio (Il verde e il rosso. Fernando Schiavetti e gli antifascisti nell’esilio, fra repubblicanesimo e socialismo, Firenze, Le Monnier, 1987) e le memorie della figlia Franca Magnani (Una famiglia italiana, Milano, Feltrinelli, 1990). Prezioso ha voluto comprendere le contraddizioni di un personaggio complesso, nato nel 1892, studente della Scuola Normale, repubblicano interventista atipico, in rivolta contro l’ambiente familiare e il padre questore, ma anche intriso di un rivoluzionarismo che privilegia la piccola borghesia e di un umanitarismo paternalista. Partito verso la Francia nel 1914 senza riuscire a combattervi, poi divenuto non interventista per non vedere la monarchia trarre vantaggio del conflitto, una volta che l’Italia entra in guerra ritrova la retorica dell’eroismo, della giovinezza, della virilità rispondendo così alla realtà del fronte, evoluzione che seguiamo passo passo grazie alla corrispondenza di guerra. Vediamo dunque nascere una descrizione brutale e piena di odio del nemico in quanto individuo, che mancava all’inizio. Tra contingenze occasionali e valorizzazione dell’ego, scopriamo pure l’elaborazione del discorso che scorge nei combattenti i soli rappresentanti qualificati del popolo, nonché il rifiuto della società civile, della retroguardia, dei pacifisti, dei socialisti e persino del PRI definito come ministeriale. Ne consegue l’accettazione dei deliri di Cadorna contro i soldati e il popolo italiano, su di un tono pre-totalitario, e l’impressione di essere stato prescelto dal fato, perché capace di sopravvivere nella battaglia. L’interventismo e il comunitarismo combattente virano verso l’antioperaismo e rafforzano la volontà di rimpiazzare le antiche élite.Questi sentimenti sono esacerbati dalla paura del ritorno alla vita civile, dal senso di declassamento, dalle difficoltà concrete e spingono ad avvicinarsi a Mussolini all’inizio del 1919: Schiavetti fonda un fascio in giugno, ma non nasconde anche la sua reticenza nelle riunioni e nelle adunate. D’altronde è totalmente estraneo alla politica imperialista, specie verso la Dalmazia, di Mussolini. Per lui la tentazione fascista dura dunque poco, come per molti futuri quadri antifascisti, e lo ritroviamo presto segretario del PRI, dove rappresenta la giovinezza, la linea intransigente, l’occasione di rilancio e l’antifascismo. Ne derivano gli attacchi di Colajanni, dei militanti romagnoli molto ostili al PSI, infine di quelli che l’hanno promosso e ora dubitano di alleanze che sembrano anticipare l’assorbimento in una organizzazione di massa. Pur se allontanato dalla segreteria, lo si ritrova in seguito alla testa del giornale di partito, La Voce repubblicana. Non rinnega il suo fascismo del 1919, ma denunzia la deriva di Mussolini, la paragona al bolscevismo e si unisce entusiasta all’Aventino, visto come un modo di portare il popolo alla democrazia e di legarsi a tutte le tendenze antifasciste, pronto a diminuire le intemperanze rivoluzionarie prima di dover prendere la via dell’esilio nel 1926.
L’esilio avrebbe potuto essere studiato con la stessa minuzia, alla luce di questa formazione e sottolineando gli elementi di continuità e di rottura. Avremmo così avuto un altro progetto e un altro libro di queste dimensioni. Ci si sarebbe allora potuti fermare alla pagina 308, cioè alla partenza dall’Italia, guadagnandoci perché quanto segue è troppo sintetico per non deludere, senza considerare l’approssimazione nella quale l’autrice cade per l’impossibilità d’immergersi nei numerosi fondi archivistici della polizia italiana e contemporaneamente per la tendenza a citare fonti polemiche. Tanto peggio: l’apporto di grande qualità di questo saggio è contenuto nelle prime trecento pagine e forse permetterà un giorno di avviare un nuovo lavoro in grado di illuminare l’esilio a Marsiglia e poi a Zurigo e di contestualizzarlo nella continuità degli anni di formazione così brillantemente esaminati.