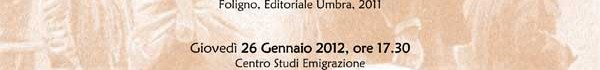Le celebrazioni del cinquantenario e i prominenti italo-americani negli Stati Uniti
Il Cinquantenario dell’Unità d’Italia (1911) e l’emigrazione
Stefano Luconi
Le celebrazioni del cinquantenario e i prominenti italo-americani negli Stati Uniti
Come è noto, il plurisecolare ritardo nel conseguimento dell’unificazione politica italiana causò la sopravvivenza di marcate forme di campanilismo che gli emigranti portarono sovente con loro nelle terre di adozione1. La frammentazione della vita associativa delle organizzazioni etniche italiane negli Stati Uniti tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento offre un’illustrazione paradigmatica della permanenza di divisioni, basate sul senso di identità regionale, provinciale o addirittura locale, nei paesi di destinazione. Fino dalla sua costituzione nel 1905 l’Ordine Figli d’Italia in America accolse nelle proprie fila qualsiasi individuo di ascendenza italiana, a prescindere dal luogo di origine nella penisola2. Tale principio, però, costituì un’eccezione, anziché la regola, in gran parte delle società mutualistiche o ricreative che gli immigrati italiani fecero sorgere negli Stati Uniti nei decenni che precedettero lo scoppio della prima guerra mondiale. La maggioranza di queste organizzazioni, infatti, tendeva generalmente ad accettare come membri soltanto gli immigrati provenienti da una specifica regione, una particolare provincia o perfino un singolo centro, escludendo chiunque – ancorché italiano – fosse nato altrove3. Un’indagine del Ministero degli Affari Esteri riscontrò che nel 1910, nella sola città di New York, erano presenti ben 338 associazioni fondate da immigrati italiani4. La denominazione di quasi tutte si rifaceva a località della penisola oppure ai relativi santi patroni, a ulteriore dimostrazione della loro natura campanilistica. Come aveva osservato l’avvocato Gino Carlo Speranza solo pochi anni prima proprio per New York, “La separazione morale della vecchia penisola è trasportata qui; ogni provincia, ogni città, ogni villaggio ha una propria società e, sebbene tutte siano collocate sullo stesso piano e abbiano uno scopo simile, non si uniscono mai nelle loro iniziative e raramente fanno in modo di unire le forze dei loro membri”5. Gli fece eco da San Francisco il giornalista Carlo Andrea Dondero, che lamentò “il tanto sfoggio di Associazioni quanti sono […] gli alti campanili d’Italia – tutte lottanti una contro l’altra”6.
Continue readingVite ritrovate – Emigrazione e letteratura italiana di Otto e Novecento
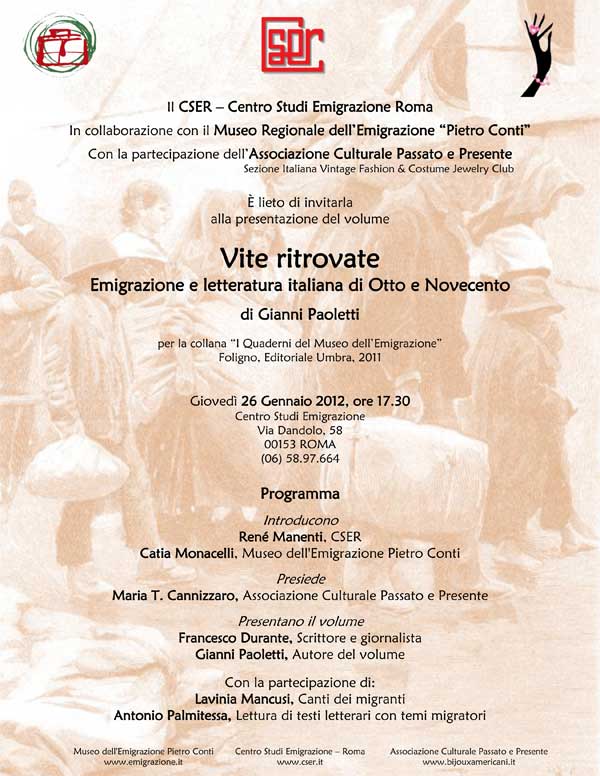
Le missioni cattoliche italiane all’estero: il caso della Consolata nella Somalia di Cesare Maria De Vecchi (1924-1928)
Daniele Natili
Le missioni cattoliche italiane all’estero: il caso della Consolata nella Somalia di Cesare Maria De Vecchi (1924-1928)
1. – Il nuovo corso politico della Somalia
L’istruzione in Somalia era rimasta fino all’anno 1924 in una forma poco più che embrionale e non rispondeva neppure alle limitate esigenze della popolazione indigena e tanto meno di quella europea nonché bene inteso alla educazione di alcuno. Nei primi mesi del 1925[…]erano giunti in Somalia a sostituire la missione dei Trinitari i Padri della Consolata[…]. Si trattava di un ordine religioso di larga e ormai matura esperienza coloniale e in modo specifico dell’Africa Orientale: da esso si poteva attendere con assoluta fede ogni buona e intensa opera anche nel campo della educazione e della istruzione […]. Anche in questo, dunque, il Regime aveva, come si è visto, in poi, fatto compiere alla Colonia anche in questo campo i dovuti progressi1.
Continue readingFrancesco Coletti e l’emigrazione
Il Cinquantenario dell’Unità d’Italia (1911) e l’emigrazione
Andreina de Clementi
Francesco Coletti e l’emigrazione
L’inizio del primo grande ciclo migratorio risaliva agli anni settanta dell’Ottocento, ma, doppiato il nuovo secolo, le grandi inchieste sociali dell’epoca continuavano a dedicare all’emigrazione italiana appena qualche sguardo frettoloso; soltanto dopo il primo decennio del Novecento fu possibile disporre di una intera monografia. La dobbiamo a Francesco Coletti.
Continue readingAsei 7
Giovanni Pizzorusso Il centenario di un cinquantenario: un’introduzione
Continue readingAmy Bernardy e il primo congresso di etnografia
Il Cinquantenario dell’Unità d’Italia (1911) e l’emigrazione
Maddalena Tirabassi
Amy Bernardy e il primo congresso di etnografia
Nel 1911, mentre tutti gli sforzi del giovane stato italiano erano concentrati sulle celebrazioni del primo cinquantennio della nazione per unificare anche culturalmente l’Italia – per portare a compimento cioè il progetto di “fare gli italiani” – un piccolo gruppo di intellettuali, radunati attorno alla scuola fiorentina di Lamberto Loria e Ferdinando Martini, introduceva in Italia l’etnografia1. La nuova disciplina si proponeva di studiare le molteplici tradizioni regionali e locali che costituivano i costumi popolari italiani. Un’operazione che, puntando l’attenzione più sulla diversità che sull’omogeneità italica, andava apparentemente controcorrente, ma che venne riassorbita nei decenni successivi nel discorso statuale. L’esame del ruolo di Amy Bernardy in questo processo consente di approfondire tale momento poco noto della storia italiana che tocca un nodo destinato a riproporsi fino ai giorni nostri.
Continue readingAppunti per una ricerca sui giornali nautici dei piroscafi italiani fra Otto e Novecento
Carlo Stiaccini
Appunti per una ricerca sui giornali nautici dei piroscafi italiani fra Otto e Novecento
1. – Racconti di viaggio
Negli ultimi trent’anni il tema del viaggio per mare si è guadagnato uno spazio sempre maggiore nel campo degli studi sul fenomeno migratorio italiano. A partire dal pionieristico lavoro di Ercole Sori, dove forse per la prima volta si segnalava, pur senza farne uso, l’importanza dei documenti di bordo dei piroscafi per la ricostruzione storica delle migrazioni transatlantiche, diversi importanti lavori hanno via via esaminato gli aspetti legati al trasporto marittimo, alle compagnie di navigazione e più in generale ai risvolti economici e sociali legati al cosiddetto trasporto di emigrazione1. A questi studi, effettuati prevalentemente grazie a documentazione prodotta dalle autorità marittime, dalle prefetture e dai ministeri preposti alla regolamentazione dei trasporti via mare, si sono affiancati negli anni lavori incentrati sulla dimensione soggettiva del viaggio per mare. Questi ultimi hanno avuto come riferimento la produzione letteraria degli scrittori di professione, più o meno noti, che avendo vissuto in prima persona l’esperienza del viaggio transoceanico, si sono poi cimentati in quello che può considerarsi un vero e proprio genere letterario2; così anche la sterminata produzione autobiografica e memorialistica della gente comune che per motivazioni anche molto differenti si è trovata ad attraversare l’oceano, anche più volte, negli ultimi centocinquant’anni3.
Continue readingL’Abruzzo migrante dall’Unità d’Italia alla Grande Guerra
Modelli Regionali di Emigrazione
Piero Berardi
L’Abruzzo migrante dall’Unità d’Italia alla Grande Guerra
1. – Il territorio e la sua economia
Gli studi sul Mezzogiorno d’Italia da qualche decennio hanno rivalutato le forme più mature dei vari aspetti della storia locale inserendoli nel più ampio ambito della storia nazionale1. In tale contesto si inquadra la storia dell’emigrazione regionale, che contribuisce ad analizzare la realtà locale dal punto di vista economico, culturale e sociale2.
Continue reading